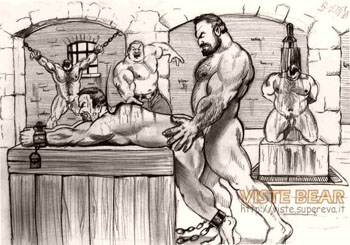|
Cose
Mai Viste Una mezza biografia non autorizzata di Viste Una premessa di VisteBear Chi è veramente VisteBear? E perché disegna orsi massicci in svariate situazioni sado maso? È un orsone manzo come quelli che disegna o è un ragazzetto alla Di Caprio? Sapevo che alcuni visitatori del mio sito si erano fatti questa domanda, ma pensavo fosse solo una semplice curiosità passeggera. L’altra curiosità invece, era quella di sapere come riesco a inventare sempre nuove torture per mettere in mostra i fisici massicci dei miei personaggi. Ma alla fine ci ha pensato Ferdinando Neri (già autore di Cerro del Diablo) a ipotizzare la mia biografia orsa e a dare una spiegazione ai miei disegni militari. Come spunto ha utilizzato dei disegni preesistenti e poi con un po’ di fantasia ci ha costruito sopra una storia. Vi chiedo solo di non prendere questa storia in modo serio… è ovvio che il protagonista si chiama come me ma non sono io… si, perché io, avrei tenuto sicuramente in mentre la strada per tornare in una caserma tanto interessante. Quindi, bravo a Ferdinando Neri e a tutti voi buona lettura. VisteBear Il racconto Il nostro bell’orso si chiamava Ernesto Bertenghi, ma per gli amici era Stive. Il soprannome glielo aveva dato il suo amico Mattia, ai tempi della scuola, una volta che lo aveva sentito cantare (un po’ stonato) “Voglio una vita spericolata, voglio una vita come Steve McQueen”. Ad Ernesto quel nomignolo era piaciuto e da allora aveva incominciato a firmare i suoi disegni Stive (con la i, non era molto bravo in inglese). In fondo Stive funzionava un po’ come nick ed anche gli amici avevano preso a chiamarlo così. Quel nomignolo gli era rimasto addosso. Se qualcuno parlava di lui chiamandolo “Ernesto”, nessuno capiva, fino a che uno diceva: “Ah, Stive! Potevi dirlo subito che era lui!”
Disegnava orsi, facce di orsi, orsi in costume e orsi senza costume. Insomma, nel caso non fosse chiaro, era attratto dagli orsi. Non disegnava orsi in particolari situazioni, semplicemente ritratti di orsi, ma di solito non faceva vedere a nessuno i suoi disegni. Forse la sua vita sarebbe continuata così, se un giorno nella tipografia non fosse stato assunto per un periodo di prova, un orso di quelli che a Stive piacevano alquanto. Glielo presentò il capo, un giovedì pomeriggio, sul tardi: - E questo, Bertenghi, è il suo nuovo collega. Lavorerà con noi per un mese, per l’ordine della Electa. Prende servizio domani mattina. Questa sera gli faccia fare un giro dei locali e gli spieghi come funziona l’azienda. Domani gli fa vedere il lavoro che sta facendo, così dalla settimana prossima lavorate insieme. Mentre il capo parlava, Stive diede un’occhiata al suo nuovo collega. Ci mancò poco che non gli sfuggisse un fischio di apprezzamento. Il tizio, di cui il capo non gli aveva neanche detto il nome, era alto una spanna buona più di lui (quindi parecchio, perché il nostro Stive non era basso), ben piantato, spalle larghe e muscoli ben torniti, tanto che la t-shirt (misura XXL) sembrava sul punto di scoppiare. Una faccia da duro, con mento squadrato, naso diritto, barba corta e due occhi verdi. Braccia possenti, coperte da una leggera peluria nera. Il rigonfio dei pantaloni era sul livello di tutto il resto, cioè molto promettente, e a Stive venne l’acquolina in bocca. Stive si alzò, sorrise e porse la mano allo sconosciuto. - Stive Bertenghi, piacere. - Giovanni Gribaudo. Voce profonda, da baritono, quasi basso. Stretta vigorosa. Stive sarebbe volentieri saltato addosso al bel Giovanni, ma così, davanti a tutti, non era proprio possibile. E poi non era detto che Giovanni gradisse e se non gradiva… erano cazzi, perché quello era un toro. Mancavano dieci minuti alla fine dell’orario di lavoro e quindi, se voleva far fare un giro al nuovo collega, era ora di avviarsi. In altre occasioni, Stive avrebbe svolto il suo compito di cicerone in cinque minuti, tanto non è che ci fossero molte cose da far vedere, ma questa volta era intenzionato a fare la guida turistica sul serio: avrebbe effettuato una visita dettagliata e approfondita, nella speranza che, in un futuro non lontano, si andasse in altri dettagli e altri approfondimenti. Giovanni parlava poco: si limitava ad annuire e a porre qualche domanda. Stive gli fece vedere tutto il laboratorio ed infine, quando ormai i dipendenti erano in buona parte andati via, accompagnò Giovanni negli spogliatoi. Gli mostrò gli armadietti e poi lo portò nelle docce. Avrebbe voluto proporgli di fare una doccia insieme, ma era un po’ prematuro, tanto più che Giovanni non aveva lavorato e non sembrava sudato. - E queste sono le docce, ma quasi nessuno le usa. Vanno tutti a casa a lavarsi. Giovanni annuì. - Io credo che le userò. Abito a trenta chilometri da qui e non ho voglia di tornare a casa tutto sudato. Qui dentro fa un caldo porco. - Hai ragione, anch’io qualche volta le uso, soprattutto in questo periodo che fa caldo. Era una bugia, almeno da un punto di vista retrospettivo, ma mettendo la frase al futuro, non lo era più: Stive aveva intenzione di usare le docce molto spesso nel mese successivo. L’idea di un mese di docce con Giovanni lo stuzzicava alquanto. A quel pensiero, incominciò a sentire una certa tensione a livello delle mutande. Quella sera, invece di desiderare che il giorno dopo non arrivasse mai, per non dover tornare a lavorare, Stive desiderò vivamente che il giorno dopo fosse già arrivato (e anche quasi finito). Quando andò a letto, non riuscì a prendere sonno: il pensiero di vedere quel magnifico esemplare di orso alpino nudo sotto la doccia era peggio di un cocktail di anfetamine sul suo cervello. Alle due di notte Stive era sveglio esattamente come a mezzogiorno. Non solo, l’immagine dell’orso nudo (nitidissima nella testa di Stive, lui era bravissimo a spogliare gli uomini con la testa) aveva un effetto quanto mai potente non sulla testa, ma su una regione situata alquanto più in basso, no, in realtà situata allo stesso livello, visto che Stive era disteso, ma con una chiara tendenza ad alzarsi da quel livello e nessuna intenzione di ritornare nella posizione abituale. Stive fu infine costretto a darsi da fare per rimettere le cose a posto, usando la mano destra. Quando infine Stive si addormentò, Giovanni tornò a visitarlo anche nel sonno. Il giorno dopo Stive lavorò a fianco di Giovanni dal mattino alla sera e questo fu piacevole, ma poco proficuo: la presenza dell’orso lo distraeva. Anche se Giovanni parlava poco, a Stive bastava sentirlo vicino a sé, avvertirne l’odore di sudore, perché la sua mente pensasse ad altro e si manifestassero reazioni incontrollabili in un’area già normalmente poco controllata. La giornata in qualche modo passò e Stive riuscì a spiegare a Giovanni quello che avrebbe dovuto fare. Arrivò infine il tanto sospirato momento delle docce. Tutti gli altri erano usciti ed erano rimasti solo loro due: Stive aveva fatto in modo di tenere Giovanni un momento di più al lavoro, in modo da dare agli altri il tempo di scomparire. Giovanni incominciò a spogliarsi, imitato da Stive, che si era messo in modo da non perdere di vista un secondo il suo orsone. Quando Giovanni si sfilò i pantaloni, Stive tirò un respiro profondo: a giudicare dalle mutande, i paesi bassi di Giovanni presentavano rilievi molto accentuati, che promettevano piacevoli escursioni. Stive sperò vivamente che Giovanni non fosse un tipo pudico, di quelli che non si tolgono le mutande, si mettono l’accappatoio quando vanno a fare la doccia e solo all’ultimo momento finiscono di spogliarsi. Giovanni si tolse le calze e poi, senza nessuna esitazione, si calò le mutande. Stive non rimase deluso, per nulla. Per dirla come la pensò Stive: Cazzo! Cazzo! Cazzo! Ebbene sì, la vista era davvero una bella vista: bella per dimensioni, di tutto rispetto; bella per la consistenza, alquanto promettente; bella per il colore un po’ scuro della pelle; bella per la peluria scura che ricopriva le palle, insomma, bella. Si accorse che anche Giovanni lo guardava, senza particolare insistenza, ma con un certo interesse. Si chiese se non lanciare un segnale, ma era una mossa azzardata: nello sguardo di Giovanni non c’era nulla che potesse leggersi come un invito. Non era il caso di bruciarsi ogni possibilità il primo giorno, meglio sondare prima il terreno. Giovanni si voltò per entrare nella doccia e Stive ebbe modo di guardarlo da dietro. Gli osservò il culo, che era un’altra bella vista: due natiche forti, peluria scura, colline ed avvallamenti boscosi, che invitavano ad una visita approfondita. Stive pensò: Cazzo! Cazzo! Cazzo! Cazzo! Stive fece la doccia quasi fredda: aveva bisogno di calmarsi, perché la vista era davvero troppo bella. A casa, con tranquillità, senza testimoni, avrebbe riesaminato la sequenza che aveva appena finito di osservare e magari l’avrebbe anche disegnata. Con la mano sinistra, perché la destra sarebbe stata occupata. Quando uscirono, non c’era più nessuno. Le loro macchine erano parcheggiate a poca distanza. Stive si chiese se non invitare Giovanni a prendere un caffè, ma si erano detti tutto quanto c’era da dire, per il momento. Giovanni non sembrava particolarmente intenzionato ad approfondire la conoscenza ed era inutile cercare di forzargli la mano. Dopo il fine-settimana, avrebbe valutato la situazione. Stive salutò, a malincuore. - Allora ci vediamo lunedì. Giovanni annuì. - Buon fine-settimana. - Grazie. Stive salì sull’auto, pulito e soddisfatto all’idea di avere davanti a sé un bel fine-settimana, con la prospettiva di ritrovare al ritorno il suo splendido orsocollega. La sua allegria durò poco: il tempo di cercare di mettere in moto l’auto e di trovarla poco collaborativa, per non dire fermamente intenzionata a non dare nessun segno di vita. Girare la chiavetta aveva sul motore lo stesso effetto di tutte le parolacce che Stive incominciò a dire. Giovanni non era ancora partito. Scese dall’auto, si avvicinò e gli chiese: - Qualche problema? - Cazzo, la macchina non parte più. Questa mattina era tutta in ordine. A quest’ora dove lo trovo un elettrauto aperto? E come vado a casa? Giovanni sorrise: - Ti posso portare io. Devo solo fare una commissione, prima, se non ti spiace. Venti minuti andiamo e torniamo. Prendere l’autobus era un casino, bisognava farsi tre chilometri a piedi per raggiungere la fermata (la tipografia era in culo ai lupi) e c’era da aspettarlo una vita. Stive non aveva neanche un biglietto e non avrebbe saputo dove comprarlo. E poi, a parte la comodità, l’idea che Giovanni gli desse un passaggio non gli dispiaceva per niente. Un’occasione per chiacchierare liberamente e per conoscere meglio il suo ben dotato orsocollega. Non si può mai dire: da cosa nasce cosa e magari in serata avrebbe potuto conoscerlo più a fondo, molto più a fondo. La fantasia di Stive correva un po’ troppo, ma tutto sommato non si sbagliava: prima di sera avrebbe conosciuto nuovi aspetti del suo collega. Poteva fare a meno dell’auto per due giorni, anche se gli rompeva un po’, e lunedì avrebbe chiamato l’elettrauto. Venti minuti ce li misero tutti solo ad andare, ma Stive non se ne preoccupò molto. Chiacchierava con Giovanni, che non era particolarmente espansivo: sembrava un po’ orso (e che cos’altro c’è da aspettarsi, da un orso?) e rispondeva alle sue domande sbrigativamente. A un certo punto Stive lanciò un’occhiata distratta al paesaggio e si stupì di vedere una strada deserta, che correva in mezzo ad un fitto bosco. Non conosceva quella zona e non sapeva dove si trovava: era stato troppo concentrato a guardare Giovanni, per cui non aveva badato al percorso seguito. Non avrebbe mai detto che in quell’area densamente abitata ci fosse una zona così selvaggia ed una strada senza traffico. Arrivarono dopo una ventina di minuti davanti ad una caserma e Stive si chiese che cazzo avesse da fare Giovanni in una caserma, ma qualunque fosse la risposta, alla caserma lo aspettavano: la barra all’ingresso si alzò senza che Giovanni dovesse fermarsi. Che strano! Attraversarono un primo cortile ed entrarono in un secondo, superando un altro posto di controllo: anche qui nessuno li fermò e la sbarra si alzò non appena la macchina si avvicinò. Giovanni accostò e spense il motore. - Scendi. Il tono di Giovanni era del tutto diverso da quello che aveva usato fino ad allora. Era stato un ordine, secco e deciso. Stive rimase un attimo interdetto, ma Giovanni era già sceso ed a Stive non rimase che ubbidire, un po’ perplesso. Giovanni era in piedi di fianco all’auto e Stive gli parlò, un po’ scocciato. - Che ti piglia? Giovanni non gli rispose. Si rivolse direttamente a un gruppo di soldati che si stavano avvicinando. - Prendetelo e portatelo dentro. I soldati circondarono Stive. - Ehi, che caz… ough! Il pugno allo stomaco tolse a Stive ogni velleità di resistenza. Due soldati lo presero per le braccia e incominciarono a trascinarlo, mentre uno gli assestò un formidabile calcio al culo, che contribuì a farlo avanzare. Stive non capiva che cosa stesse succedendo. Era incazzato nero, ma i soldati erano in otto, tutti piuttosto massicci, e lo tenevano ben saldo. Stive si ritrovò in uno stanzino ed i soldati incominciarono a spogliarlo. Stive oppose resistenza solo per un decina di secondi, poi un nuovo pugno allo stomaco lo convinse, con la forza della sua argomentazione, che era più saggio lasciar fare. L’essere spogliato da un gruppo di uomini muscolosi e massicci era uno dei sogni ricorrenti di Stive, ma il nostro eroe non avrebbe mai pensato che si realizzasse in quel modo. Non fu eccitante com’era nelle sue fantasie, anche perché Stive era ancora dolorante per i due pugni presi, ma quelle mani forti che gli toglievano gli abiti, carezzandogli brutalmente la pelle, gli trasmettevano un brivido tutt’altro che spiacevole. Quando ebbero finito, i soldati gli legarono le mani dietro la schiena. Poi uno di loro, un Ercole che indossava solo un paio di calzoncini corti, lo spinse lungo una scaletta che scendeva nei sotterranei. Al fondo della scala c’era un vasto stanzone. Stive diede un’occhiata e rimase senza fiato: diversi uomini massicci erano legati o incatenati, alla parete, a pali di legno o su piattaforme. Vicino ai prigionieri c’erano alcuni soldati, altrettanto muscolosi, che li stavano torturando.
Stive realizzò che l’uomo ce l’aveva duro. Anche gli altri prigionieri ce l’avevano duro, tutti. Come facessero, in quelle condizioni, Stive non riusciva a capirlo, ma era così: sembravano tutti sul punto di venire, anche se le loro facce esprimevano sofferenza. Il soldato lo guidò fino a una piattaforma circolare, dove lo aspettavano altri quattro uomini. Gli legarono le mani a una sbarra di ferro posta in alto, poi lo costrinsero a salire sul basamento. Stive dovette mettersi in ginocchio, per non urtare con la testa una doccia posta proprio sopra la piattaforma. Non era una posizione comoda, perché doveva tenere le braccia sollevate. Inoltre faceva un caldo fottuto, in quello stanzone: sembrava di essere in un bagno turco. Stive quasi invidiò l’uomo sotto la doccia gelata. I soldati lo mollarono lì e Stive ebbe modo di osservare quanto avveniva intorno a lui. Non era una bella vista. O meglio: sarebbe stata una bella vista, se uno avesse potuto guardarla come spettatore, ma Stive sapeva benissimo che il suo ruolo non sarebbe stato solo quello. Era combattuto tra la paura per ciò che gli sarebbe toccato e l’interesse per lo spettacolo che gli si offriva. Ad attrarre la sua attenzione fu soprattutto l’uomo legato sopra il vapore ardente. Il viso era ormai paonazzo e il sudore formava una patina sulla sua faccia e faceva luccicare la peluria che gli ricopriva il torace, il ventre e le gambe: il calore doveva essere intollerabile. L’uomo sembrava sul punto di svenire e la testa ciondolava in avanti. Il soldato continuava a sfregargli il manganello tra le chiappe e ad un certo punto l’uomo spalancò gli occhi ed ebbe un guizzo disperato: tutto il suo corpo si tese in uno spasimo violento. Stive guardò la mano del soldato che stringeva il manganello e vide che l’asta era entrata nel culo dell’uomo per più di metà. Il prigioniero si contorceva, nel tentativo di sfuggire a quell’assalto, il viso deformato dal dolore. Eppure ce l’aveva ancora duro, perfettamente teso. In quel momento aprirono il getto d’acqua sopra l’uomo, che sussultò di nuovo. Stive fissava affascinato quella scena, ma proprio in quel momento vide che un uomo molto massiccio, con una frusta in mano, gli si stava avvicinando. Capì immediatamente: ora era il suo turno. Aveva una fifa dannata. Ma non solo fifa. Anche il suo uccello si era teso. Stive non avrebbe saputo spiegare, non cercava neanche di capire, ma la tensione che gli saliva dal ventre era fortissima. Il getto di acqua gelida lo prese di sorpresa: anche se aveva visto la doccia sopra di sé, non se l’aspettava. Rabbrividì tutto.
L’acqua smise di scendere. Allora il soldato gli appoggiò il manico della frusta sotto il mento, mentre la lingua di cuoio sembrava accarezzare il corpo di Stive, promettendo e minacciando. - Pronto? Stive non rispose: qualunque cosa avesse detto, non sarebbe cambiato nulla. Ma non era solo questo: se una parte di lui si ritraeva di fronte alla fustigazione che lo aspettava, qualche cosa in lui sembrava invece desiderarla. Era davvero pronto, nonostante la paura che gli stringeva le viscere. L’uomo si mise dietro di lui. Stive attese. Il primo colpo sulla schiena lo fece sussultare. Non era mai stato frustato, realmente (qualche gioco hard l’aveva fatto, ma poca roba): non si aspettava quel dolore secco e violento. Il secondo colpo, al culo, fu ancora più forte. Il terzo, di nuovo al culo, gli strappò un gemito, che Stive cercò di soffocare per orgoglio. I due colpi successivi, nella parte alta della schiena, gli fecero venire le lacrime agli occhi. Quel figlio di puttana ci dava dentro, doveva divertirsi. Stive era forte, ma i colpi si susseguivano, senza dargli tregua. La vista gli si annebbiò e Stive sentì che era sul punto di svenire per il dolore. Eppure, anche mentre sentiva che le forze lo abbandonavano, la tensione dentro di lui rimaneva fortissima ed il cazzo, duro come l’acciaio, gli batteva contro il ventre. Si accorse in quel momento che i colpi erano cessati. L’uomo gli stava passando di lato, era davanti a lui. Lo guardò. Il soldato sorrideva. Sulle mutande aveva un’ampia macchia bagnata. Gli passò il manico della frusta intorno all’uccello e quella carezza fece gemere Stive. Poi fece scivolare la frusta sotto le palle. Stive avrebbe voluto urlare per la tensione che cresceva in lui. La frusta ritornò ad accarezzare l’uccello e Stive sentì un uragano che si scatenava dentro di lui, un uragano di piacere e di dolore, mentre il suo seme si scagliava in alto e irrorava il torace del soldato davanti a lui. Questi sorrise, si voltò e si allontanò. Lo lasciarono lì a lungo. Nello stanzone erano rimasti solo i prigionieri. Stive vide che nessuno di loro era ancora eccitato. Erano venuti tutti, come lui? Non avrebbe saputo dirlo. Era intontito dal dolore. Le braccia gli dolevano per la posizione innaturale a cui lo costringevano le catene. Poi vennero a slegarli e li accompagnarono ognuno in una cella. Stive si chiese a lungo dove fosse finito, ma non sapeva darsi nessuna risposta convincente. Come era possibile che degli uomini venissero rapiti e torturati in una caserma che doveva ospitare decine o, più probabilmente, centinaia di soldati? Come era possibile che in Lombardia, in provincia di Varese (se Giovanni non l’aveva portato fuori dalla provincia, ma Varese o Como o che cos’altro fosse, poco cambiava) ci fosse una caserma di quel genere e nessuno lo sapesse? Le domande rimasero senza risposte e infine Stive, esausto dopo una giornata di lavoro ed una serata nella stanza delle torture, si addormentò. Il giorno seguente lo accompagnarono in cortile e gli legarono le mani ad un grande anello, messo in cima ad un palo. Stive era costretto a tenere le braccia sollevate e piegate e ad appoggiarsi con la schiena al palo. Pensò che almeno non l’avrebbero frustato da dietro: questa era una buona cosa, perché il culo e la schiena gli facevano un male porco. Stive non era solo nel cortile: vi erano diversi uomini legati, che venivano frustati o torturati in vari modi. Alcuni avevano pesi attaccati ai capezzoli, altri erano costretti a stare con le braccia tese all’infuori, reggendo qualche carico, ed ogni volta che abbassavano le braccia, ricevevano una frustata. Stive guardò quegli uomini, che avevano una smorfia di dolore sul viso sudato: quasi tutti ce l’avevano duro. Anche a Stive venne duro piuttosto in fretta. Il sole era caldo e lo faceva sudare parecchio, ma la posizione di Stive, per quanto scomoda, era di sicuro migliore di quella degli altri prigionieri che poteva vedere. A lui almeno non stavano facendo niente. Per il momento, almeno. Il momento non durò molto. Un soldato, massiccio come tutti gli altri ed a torso nudo, gli passò accanto. - Vado a prendere l’occorrente e sono da te. L’uomo scomparve alle sue spalle. Stive non poteva voltarsi, ma dopo un po’ sentì dietro di sé la voce del soldato. - Scusa se ti abbiamo fatto aspettare, ma spero che tu abbia apprezzato lo spettacolo.
Stive si sentiva inquieto. L’uomo non avrebbe potuto frustarlo da dietro. Che cosa intendeva fare? L’inquietudine non spense la sua eccitazione: l’uccello sembrò tendersi ancora di più. L’uomo passò davanti a lui e lo guardò. Sorrideva. Stive si rese conto di sudare abbondantemente. L’uomo fece un rapido movimento ed una staffilata si abbatté sul torace di Stive, lasciandogli un segno rosso. Stive spalancò la bocca, ma trattenne l’urlo. Seguirono altri colpi. Ogni volta Stive guardava affascinato il braccio dell’uomo sollevarsi e poi il movimento rapido, a cui seguiva la bruciatura del cuoio sulla pelle. Guardando l’uomo, Stive realizzò quanto essere frustati da davanti fosse diverso dall’essere frustati sulla schiena: vedere l’aguzzino alzare il braccio permetteva di anticipare il colpo ed il dolore, senza l’incertezza dell’attesa. I colpi si susseguivano e Stive si chiese se la frusta sarebbe scesa più in basso, perché se quei colpi avessero incontrato l’uccello teso, Stive preferiva non pensare a quello che sarebbe potuto succedere. L’uccello non pensava (d’altronde, si sa, non è il suo forte), si limitava a rimanere teso come una mazza di ferro, indifferente a ciò che avveniva sopra di lui (o forse stimolato da quanto si svolgeva ai piani alti). Stive ricevette solo una decina di colpi, ma la giornata non era finita. Quando fu slegato, Stive fu accompagnato in un altro cortile, dove lo incatenarono ad una specie di grande slitta, su cui si trovava un blocco di pietra, e lo costrinsero a tirare. Se al palo Stive aveva avuto l’impressione di essere sudato, dopo cinque minuti di traino si rese conto che prima di iniziare a tirare era fresco come una rosa. Adesso il sudore gli colava in rivoli sulla faccia e su tutto il corpo, annebbiandogli persino la vista. Avrebbe voluto smettere di tirare, ma il soldato con i baffi, che accarezzava la frusta di fianco a lui, non doveva essere stato messo lì solo perché Stive avesse modo di apprezzare il suo fisico (alquanto robusto e invitante, va detto: peccato solo che Stive non fosse nelle condizioni migliori per apprezzarlo pienamente). Stive crollò due volte: la prima, un colpo di frusta fu sufficiente a rimetterlo in piedi. La seconda, ce ne vollero tre ed il terzo gli lacerò la pelle, facendo colare il sangue. Quando Stive cedette nuovamente, non venne più frustato. E nessuna frusta al mondo sarebbe riuscita a fargli ancora tirare quel peso. Gli tolsero le catene, gli diedero da mangiare e poi lo riportarono in cortile, dove passò alcune ore a trasportare sacchi di sabbia sulla schiena, sempre con l’accompagnamento di una frusta, pronta a suscitare nuovi slanci nei pigri e negli stanchi. La tela ruvida dei sacchi sfregava sulle ferite e Stive maledisse i soldati, la caserma, Giovanni (che non aveva più rivisto) e tutto il mondo, ma ogni volta che dava segni di cedimento, una frustata sul culo lo aiutava a scoprire riserve insospettate di energia. Quando lo riportarono in cella, dopo avergli dato da mangiare, Stive era esausto. Anche quella notte, prima di addormentarsi, Stive si mise a riflettere. Era sabato sera. Magari gli amici si sarebbero stupiti di non sentirlo e i suoi genitori anche, ma probabilmente un allarme vero e proprio non sarebbe scattato fino al lunedì: la sua assenza sul lavoro avrebbe reso evidente la sua scomparsa. E poi? Come trovarlo in quella caserma, dove avvenivano le cose peggiori senza che nessuno se ne preoccupasse? Stive si addormentò senza aver trovato risposte alle sue domande. Il giorno dopo lo portarono nuovamente nella sala sotterranea. Questa volta lo incatenarono a un grosso blocco di legno, il torace ed il ventre contro il piano superiore, le gambe contro uno dei lati, un po’ divaricate. La presenza di un soldato dai capelli grigi e una frusta in mano diede a Stive un’idea sufficientemente chiara di quello che lo aspettava. Avrebbe preferito tirare la slitta o trasportare sacchi, perché la schiena e il culo erano ancora doloranti, ma Stive aveva capito che le sue possibilità di scelta erano, come dire?, ridotte. Vide l’aguzzino sollevare la frusta e strinse i denti per non urlare. Nonostante si aspettasse il colpo, fece fatica a trattenere l’urlo, perché la frustata fu forte e gli lacerò la pelle. Mentre aspettava il secondo colpo, vide un uomo avvicinarsi. Era Giovanni. Era nudo, con il bell’uccello in tiro (una splendida vista, che in qualsiasi altro momento Stive avrebbe apprezzato moltissimo) e per un attimo Stive si chiese se non fosse anche lui prigioniero, ma era evidentemente una cazzata. Solo quando Giovanni passò dietro di lui, Stive intuì che cosa stava per succedere. L’avere intuito non aumentava le sue possibilità di scelta, chiaramente nulle. Sentì la pressione di un uccello alquanto voluminoso contro il suo culo e poi la voce beffarda di Giovanni: - In fondo era quello che volevi, no? Forse era vero (ma avrebbe potuto essere anche il contrario, Stive era aperto a possibilità diverse), ma Stive sentì la rabbia salirgli dentro. - Va’ a farti fottere. Sentì la risata roca di Giovanni. - Temo che tocchi a te, questa volta, farti fottere. Giovanni spinse con decisione e Stive sentì un dolore violento al culo, mentre l’arma di Giovanni entrava a fondo dentro di lui e una seconda frustata si abbatteva sulla sua schiena. Spalancò la bocca, ma non urlò.
Stive fu più volte sul punto di venire, ma la frusta che periodicamente si abbatteva su di lui raffreddava il suo entusiasmo. Poi la tensione riprendeva a salire, sempre più forte, fino a una nuova frustata. Improvvisamente le spinte divennero tanto violente da essere intollerabili e, proprio mentre sentiva che le viscere gli si riempivano del seme di Giovanni, Stive venne. Un’ultima frustata accompagnò il gran finale. Stive aveva goduto con una violenza incredibile, che lo aveva lasciato stordito. Ora però, mentre Giovanni usciva da lui, era il dolore che si faceva sentire: alla schiena, per le frustate ricevute; al culo, per lo schidione che l’aveva infilzato. La voce di Giovanni lo ricondusse bruscamente alla realtà. - Con questo è fatta. Portatelo in infermeria, che domani lo fuciliamo. Stive rimase senza parole (non che le parole potessero servire a molto in quella situazione), paralizzato dalla paura (non che potesse muoversi, legato com’era): non aveva riflettuto su che cosa avrebbero potuto fargli, dopo averlo torturato, e non aveva mai pensato che potessero decidere di ammazzarlo. Quattro soldati lo accompagnarono in infermeria, dove un medico disinfettò le ferite (e fu quasi peggio delle frustate). Aveva appena finito, quando si sentì una scarica di fucileria. Stive sgranò gli occhi: dopo la frase di Giovanni quei colpi avevano un significato preciso e Stive fu preda di un terrore cieco. Un momento dopo entrò un soldato. - Può venire, dottore? C’è un problema. - Vengo subito. Il dottore uscì. Stive aveva recuperato la lucidità. Sapeva che doveva agire subito: era la sua unica possibilità di salvarsi. Si alzò e si guardò intorno alla ricerca di qualche cosa da indossare: doveva scappare, ma non poteva farlo nudo, chiunque l’avesse visto, anche da lontano, lo avrebbe immediatamente individuato come un prigioniero in fuga. In un angolo c’erano alcuni armadietti. Stive ne aprì uno, ma non conteneva niente di utile. Nel secondo c’erano invece alcuni indumenti: prese una camicia ed un paio di pantaloni. Con cautela si affacciò sul cortile. Non c’era nessuno e questo lo stupì alquanto. Non avevano appena fucilato un prigioniero? Qualunque fosse il motivo, lui poteva solo essere ben contento che non ci fosse nessuno. Si diresse velocemente verso un portone. Non sapeva bene che cosa avrebbe fatto, ma non aveva tempo per formulare un piano. Doveva cercare di uscire da quella fottuta caserma il più in fretta possibile e scomparire. Raggiunse il portone. Non c’era nessuno. Neppure una sentinella? Impossibile! Eppure sembrava essere così. Stive uscì rapidamente e si trovò su una strada. Camminò in fretta, infilandosi subito nel bosco. Cercò di non urlare quando mise il piede su alcuni rovi: camminare in un bosco a piedi nudi non è piacevole, ma finire davanti al muro con dodici fucili puntati addosso è ancora meno piacevole! Marciò a lungo, senza sapere dove stesse andando: badava solo ad allontanarsi il più possibile dalla caserma. Per fortuna stava diventando buio e non lo avrebbero trovato facilmente, a meno che non avessero i cani. Arrivò infine su una strada con un po’ di traffico e provò a fare l’autostop. Non contava molto su un passaggio: vedeva pochissime auto e lui, così, a piedi nudi, non doveva apparire propriamente raccomandabile. Ma magari non si sarebbero accorti che non aveva le scarpe. Un’auto si fermò quasi subito. Il conducente andava proprio a Solbiate Arno, dove stavano i genitori di Stive. L’uomo lo fece salire e gli chiese come mai girava a piedi nudi. Stive si inventò che era stato derubato. Il tizio era curioso e Stive dovette costruire tutta una storia, così, su due piedi (pure scalzi). Venne fuori un’avventura forse non del tutto verosimile, ma certamente più credibile della verità. Concentrato nell’invenzione della rapina, Stive non badò alla strada e solo dopo alcuni chilometri si rese conto che non avrebbe saputo dire dove era stato caricato e che percorso avevano fatto. Lo chiese all’uomo, ma questi non si ricordava il punto esatto dove l’aveva raccolto, conosceva poco quella strada, l’aveva presa perché sulla statale c’era una deviazione per lavori in corso. Sapeva solo dire che era prima di Gallarate. - E poi, che te ne frega, alla polizia non serve mica sapere dove ti hanno lasciato. L’uomo si offrì di riaccompagnarlo alla stazione di polizia, ma Stive non aveva nessuna intenzione di andarci. Voleva pensarci su con calma. Stive si fece lasciare dai suoi, che, vedendolo vestito in quella maniera e a piedi nudi, capirono subito che era successo qualcosa. Stive raccontò anche a loro che era stato rapinato per strada e che gli avevano rubato pure le scarpe. I suoi cercarono di convincerlo a sporgere denuncia, ma Stive replicò che non sarebbe servito a nulla. Si fece dare le chiavi di casa sua, di cui i genitori avevano una copia, e suo padre lo accompagnò in auto. Quando aprì la porta, si accorse che c’era solo lo scatto: o lui non aveva chiuso a chiave quando era uscito, venerdì, o qualcuno… Non completò il pensiero. Rabbrividì e rimase fermo sul pianerottolo, di fronte alla porta. Spinse con cautela il battente. Buio e silenzio. Si fece coraggio e si decise ad entrare: era difficile che lo rapissero nel suo appartamento. Fece un rapido giro di esplorazione, ma quando accese la luce in camera da letto, rimase senza fiato: sul letto c’erano i suoi vestiti e per terra le sue scarpe. Erano venuti a restituirgli le sue cose e c’era davvero tutto, comprese le chiavi dell’appartamento. Stive si chiuse in casa, poi cercò di riflettere. Probabilmente gli spari, le parole di Giovanni (che Dio solo sa come si chiamava davvero), la mancanza di sentinelle, tutto era stato organizzato per spingerlo a scappare. Ma perché? Perché lo avevano rapito, per poi rilasciarlo? E chi erano? Rimase a lungo a chiedersi che cosa fare. Sporgere denuncia? Difficile che gli credessero, a meno di non trovare la caserma, ma lui non aveva un’idea di dove fosse. E aveva paura di ficcarsi nei guai. Lo avevano lasciato andare via, era meglio che dimenticasse quella storia. L’indomani Stive si fece accompagnare al lavoro da un collega. Prima di entrare, provò ad avviare l’auto: partì al primo tentativo. Come Stive aveva intuito, era stata manomessa, ma qualcuno l’aveva poi risistemata. Al lavoro Gribaudo non si fece vivo. Stive non ne fu stupito. Per alcuni giorni Stive visse nella paura di essere nuovamente catturato, ma non successe nulla di anomalo. L’unico inconveniente fu che gli toccò fare il lavoro tutto da solo, mentre il capo smaniava per la scomparsa di Gribaudo, non riuscendo a capacitarsi che uno appena assunto scomparisse così, nel nulla. Stive avrebbe potuto spiegargli, ma la spiegazione non sarebbe stata molto convincente. Una di quelle sere, a casa, si mise a disegnare le scene a cui aveva assistito nella camera delle torture. Poi fece uno schizzo di se stesso legato al palo, modificando un po’ i tratti: preferiva non essere riconoscibile, anche se quei disegni non li avrebbe mai visti nessuno. E man mano che la matita procedeva per la sua strada e le immagini prendevano forma, sentiva una tensione violenta salirgli dentro. La cosa finì com’era prevedibile: dovette sospendere il disegno e dedicarsi ad altra attività. Nei giorni seguenti, dopo aver riportato sulla carta le scene che aveva vissuto o a cui aveva assistito, passò ad immaginare altre scene in cui uomini massicci venivano torturati. Con lo stesso effetto. Disegnare orsi muscolosi legati, frustati, torturati, umiliati, divenne la sua occupazione preferita. Un giorno uno di questi schizzi, lasciato casualmente sulla scrivania, fu visto da un amico con cui Stive aveva trascorso la notte (non a giocare a carte). Il tipo apprezzò molto il disegno ed allora Stive gliene fece vedere alcuni altri. L’amico gli suggerì di proporli a qualche rivista: conosceva l’editore di un periodico per orsi (e amanti degli orsi), che secondo lui li avrebbe pubblicati volentieri. Stive preparò una serie di tavole. Prima di dare via materiale suo, decise di metterci almeno un nome, per evitare che magari qualcun altro li facesse passare per propri. Pensò di firmare Stive, ma tutti lo conoscevano come Stive e non aveva voglia che chiunque potesse fare un collegamento tra quei disegni e lui. Meglio essere prudenti. Allora decise di anagrammare il suo nome: dopo Vesti (per un negozio di abbigliamento) ed Estiv (ideale per una marca di costumi da bagno), Svite (inutilizzabile, dopo la chiusura dei manicomi) e Et Vis (viagra per latinisti), venne infine fuori un Viste, che lo convinse. E così Stive divenne il famoso disegnatore Viste. 2007 |
 Stive lavorava dalle parti di
Stive lavorava dalle parti di  C’era un uomo legato in
ginocchio sotto il getto di una doccia che lo prendeva in pieno: doveva
essere acqua gelida, perché il prigioniero rabbrividiva. Un altro aveva le
braccia bloccate in alto, a due anelli fissati alla parete, e una guardia gli
stava martoriando i capezzoli. Quello che colpì di più Stive fu un terzo
uomo: era legato a due pali, sopra un’apertura da cui uscivano vapori
ardenti. Era coperto di sudore, che scendeva a rivoli lungo l’ampio torace
villoso, e un soldato gli stava premendo una specie di grosso manganello
contro il culo. Una smorfia di dolore gli contraeva la faccia, mentre il
soldato ghignava.
C’era un uomo legato in
ginocchio sotto il getto di una doccia che lo prendeva in pieno: doveva
essere acqua gelida, perché il prigioniero rabbrividiva. Un altro aveva le
braccia bloccate in alto, a due anelli fissati alla parete, e una guardia gli
stava martoriando i capezzoli. Quello che colpì di più Stive fu un terzo
uomo: era legato a due pali, sopra un’apertura da cui uscivano vapori
ardenti. Era coperto di sudore, che scendeva a rivoli lungo l’ampio torace
villoso, e un soldato gli stava premendo una specie di grosso manganello
contro il culo. Una smorfia di dolore gli contraeva la faccia, mentre il
soldato ghignava.